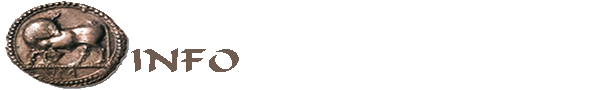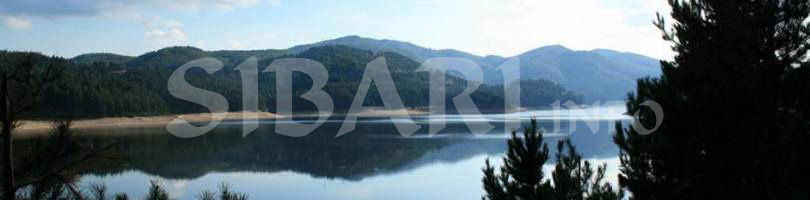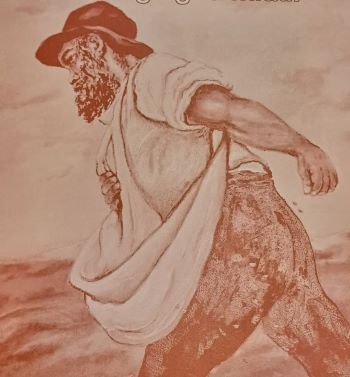 Cari amici, giorni fa mi è capitato per caso tra le mani un opuscoletto nella sala d’attesa di un amico tecnico elettronico di Corigliano. Si tratta di un piccolo stampato, soltanto quattro facciate, contenente alcuni detti popolari calabresi diffusi un po’ in tutta la regione. I termini utilizzati in questo caso sono di un dialetto cosentino della zona centrale della provincia, ma comprensibili, credo, in tutto il territorio. Comincio a presentarvene qualcuno, se piaceranno pubblicherò poi anche il resto. L’estensore di questo simpatico opuscolo si firma Bernardino Baciccia, successivamente, però, ho scoperto che si tratta di un nome di fantasia, quindi non sono in grado di potervi comunicare, almeno per il momento, il vero nome della persona che ha diffuso questa interessante pubblicazione. (Tonino Cavallaro)
Cari amici, giorni fa mi è capitato per caso tra le mani un opuscoletto nella sala d’attesa di un amico tecnico elettronico di Corigliano. Si tratta di un piccolo stampato, soltanto quattro facciate, contenente alcuni detti popolari calabresi diffusi un po’ in tutta la regione. I termini utilizzati in questo caso sono di un dialetto cosentino della zona centrale della provincia, ma comprensibili, credo, in tutto il territorio. Comincio a presentarvene qualcuno, se piaceranno pubblicherò poi anche il resto. L’estensore di questo simpatico opuscolo si firma Bernardino Baciccia, successivamente, però, ho scoperto che si tratta di un nome di fantasia, quindi non sono in grado di potervi comunicare, almeno per il momento, il vero nome della persona che ha diffuso questa interessante pubblicazione. (Tonino Cavallaro)
Disamina di alcuni detti popolari
Jennu, diciennu – Andando, dicendo:.
Jennu diciennu, che abbiamo tradotto, andando dicendo, e l’accostamento di due verbi: andare e dire. Nel suo contesto può assumere il semplice significato di andare da… Per dire che… Per esempio: andare dal medico per dirgli che non ci si sente bene; ma così com’é, la frase esprime piuttosto: “andando per… dicendo che…” Per esempio: andare per le vie del paese, dicendo che…
Può trattarsi di un bando pubblico; di un pettegolezzo; di una calunnia; di una nuova notizia, buona o cattiva che sia e così via dicendo di tale detto; vi è tuttavia un’ultimo accorgimento da rilevare, e cioè: il verbo andare, che qui traduce jennu “, implica avanzare, costruire un discorso con le parole, edificare quindi, spingere al bene, alla virtù con l’uso dei discorsi.
Nel principio erano i cantastorie, i narratori, i poeti e soprattutto i filosofi che jivinu diciennu. Oggi ognuno va dicendo, ma non si capisce cosa, o, altrimenti, si capisce una cosa per un’altra, in questo caso, molto più che l’ignoranza di chi ascolta c’è la furbizia di colui che va diciennu.
A vucca è ‘nna ricchizza
La bocca è una ricchezza (va precisato che vucca-bocca, qui, è sinonimo di lingua).
Molto probabilmente la metafora di questo detto alquanto incisivo, trova le sue radici nelle parole che l’apostolo Giacomo dichiara nella sua lettera indirizzandola alle 12 tribù disperse nel mondo:
“fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo il più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da fieri venti impetuosi sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro del corpo, eppure si vanta di grandi cose. Osservate: un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, e il mondo dell’iniquità posta com’è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiammata dalla geenna, dà fuoco al ciclo della vita”. (Giacomo 3:1-6)
Certo, nel contesto, Giacomo pone la lingua al cospetto della purezza della santità di Dio e, il fatto che la sua lettera sia indirizzata alle 12 tribù di d’Israele che sono disperse nel mondo, ci induce a pensare che il resto dell’umanità ne sia escluso. Nel nostro ambito, tuttavia, la lingua rimane pur sempre un piccolo membro che si vanta di grandi cose: na ricchizza, appunto.
Simina quannu vu’ ca a giugnu mìeti
(semina quando vuoi che a giugno mieterai)
La semina del grano ha un periodo abbastanza lungo che va da fine ottobre a inizio dicembre, e riguardo a questo lavoro, la saggezza popolare ha coniato tanti detti.
Un detto dice: “Ppe Sant’Andria, u buonu massaru siminatu avija” (per Sant’Andrea il buon massaro seminato aveva) . È la voce della saggezza a ricordare che il buon amministratore agricolo, per il 30 novembre, appunto Sant’Andrea, ha già portato a termine il lavoro della semina. Un altro detto invece ricorda: “a Santu Linardu simina ca è tardu” (a San Leonardo, il 6 di novembre, semina che è tardi).
Come si nota dai detti antichi, il meridione, favorito da un clima temperato, per la semina del grano predilige il periodo che incorre tra il sei e 30 novembre. In questo periodo semina quando vuoi perché senz’altro a giugno mieterai; c’è tuttavia un aspetto ironico e poi anche uno sarcastico che commentiamo così: un tizio deve fare un suo lavoro ma, poveretto, indeciso su quando farlo, chiede all’amico un suo parere, questi, ridendosela sotto i baffi gli risponde a mò del nostro detto: “Simina quannu vu’ ca a giugnu mìeti” cioè “fallo quando vuoi e stai tranquillo quando avrai finito sarai contento e poi mieterai”. La metafora della risposta sarcastica invece suonerà così: “tu non perdi né tempo né occasione a seminare discordia, ma sappi che arriva certamente il momento in cui la pagherai”.