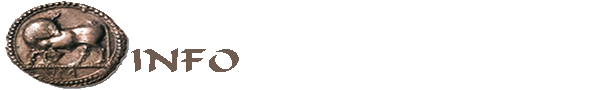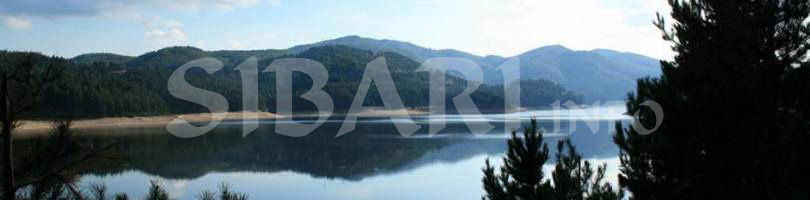Lo sviluppo e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale ha creato, e crea tuttora, parecchie titubanze e preoccupazioni tra i fruitori professionali di moderne tecnologie informatiche e non solo. La diffusione di questo nuovo potente mezzo telematico sta sconvolgendo il modo di utilizzo del web sia in fase di ricerca di informazioni che nell’elaborazione di dati, che possono ora essere manipolati e personalizzati in modo molto più semplice e rapido. Tutto ciò comporta la necessità di una sempre maggiore richiesta di “sicurezza” dei dati sensibili di ogni fruitore sia esso privato che pubblico. Abbiamo chiesto al prof Sergio Niger, (Docente di Aspetti etici e giuridici dell’informatica presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, specificatamente nei corsi di Laurea in Informatica, dell’Università della Calabria) , lo stato dell’arte riguardo al problema della difesa delle nostre “proprietà informatiche personali” che sembrano ora essere lasciate quasi in balia del “ludibrio delle genti”, visti i continui “furti” di profili che si subiscono nei tanti socials a disposizione e che utilizziamo oramai quotidianamente. Ci ha inviato alcune sue considerazioni sull’Intelligenza Artificiale che proponiamo di seguito, sicuri che susciteranno notevole interesse. Ringraziamo il prof. Niger per la disponibilità e auguriamo BUONA LETTURA ai nostri affezionati webnauti. (La redazione)
Lo sviluppo e la diffusione dell’Intelligenza Artificiale ha creato, e crea tuttora, parecchie titubanze e preoccupazioni tra i fruitori professionali di moderne tecnologie informatiche e non solo. La diffusione di questo nuovo potente mezzo telematico sta sconvolgendo il modo di utilizzo del web sia in fase di ricerca di informazioni che nell’elaborazione di dati, che possono ora essere manipolati e personalizzati in modo molto più semplice e rapido. Tutto ciò comporta la necessità di una sempre maggiore richiesta di “sicurezza” dei dati sensibili di ogni fruitore sia esso privato che pubblico. Abbiamo chiesto al prof Sergio Niger, (Docente di Aspetti etici e giuridici dell’informatica presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, specificatamente nei corsi di Laurea in Informatica, dell’Università della Calabria) , lo stato dell’arte riguardo al problema della difesa delle nostre “proprietà informatiche personali” che sembrano ora essere lasciate quasi in balia del “ludibrio delle genti”, visti i continui “furti” di profili che si subiscono nei tanti socials a disposizione e che utilizziamo oramai quotidianamente. Ci ha inviato alcune sue considerazioni sull’Intelligenza Artificiale che proponiamo di seguito, sicuri che susciteranno notevole interesse. Ringraziamo il prof. Niger per la disponibilità e auguriamo BUONA LETTURA ai nostri affezionati webnauti. (La redazione)
Ogni giorno sentiamo parlare di Intelligenza Artificiale in tutti gli ambiti della nostra esistenza. Molto spesso si invocano nuove regole per disciplinare un tema che solleva problemi etici, oltre che teorici e pratici. Ma quali regole? Con quali obiettivi? E quali sono le regole davvero necessarie? L’IA ci sfida a elaborare nuovi paradigmi sia teorici che etico-giuridici.
Un gruppo di scienziati del California Institute of Technology ha pubblicato nel mese di luglio del 2024 uno studio “Nature Human Behaviour”in cui ci racconta di impianti cerebrali in grado di decodificare il linguaggio interno, identificando le parole cui due persone hanno pensato senza muovere le labbra né emettere alcun suono. Questo studio è il primo a cogliere dall’esterno parole solo “pensate”, registrando in tempo reale l’attività di singoli neuroni. Si tratta del sogno (o dell’incubo) della letteratura della mente, che le nuove neurotecnologie stanno rendendo sempre più concreto. È, quindi, urgente una riflessione sulla prossima diffusione di questi sistemi, lo ha fatto la studiosa Nita Farahany nel suo ultimo libro: Difendere il nostro cervello. La libertà di pensiero nell’era delle nuove tecnologie (Bollati Boringhieri, 2024), oggi una delle voci più autorevoli sulla c.d. “privacy cerebrale”.
L’IA fa paura, non solo perché è una tecnologia dirompente e la parola intelligente evoca una soggettività altra, ma anche perché lo sviluppo dell’IA è stata preceduta da decenni di espressioni culturali, letterarie, cinematografiche, che ne hanno fatto un mito. Si è fatto ricorso proprio al linguaggio del mito più che a quello specialistico, parole adoperate per riferirsi alle dirompenti innovazioni digitali che hanno contribuito a rafforzare il pregiudizio attraverso il quale approcciamo queste tecnologie. Spesso i termini utilizzati richiamano antiche paure. In un’epoca dominata dall’ansia viviamo anche quella generata dalla tecnologia, che si prospetta come la grande paura che essa ci possa sopraffare e dominare.
“Come farà l’uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla normalmente arma di progresso?”. Nell’interrogativo posto nel 1953 da Giuseppe Ungaretti vi è tutta la consapevolezza tragica della complessità del rapporto tra l’uomo e la macchina, ma anche l’aspirazione a un governo antropocentrico e filantropico della tecnica.
Grandi opere letterarie, anche di recente, hanno messo in luce questo rapporto, si pensi alle ultime opere di Kazuo Ishiguro o di Ian McEwan, così come Fei-Fei Lì nel suo ultimo libro “Tutti i mondi che vedo”, un potente appello a mantenere l’umanità al centro della nostra ultima trasformazione tecnologica. La profondità di questo interrogativo è ancora oggi irrisolto, il nostro approccio alla tecnica appare oscillante tra un acritico entusiasmo per il soluzionismo tecnologico e un nuovo ingiustificato neoluddismo.
Papa Francesco, che guarda sempre all’orizzonte e pone uno sguardo sulle questioni di frontiera, alle sfide che l’umanità si trova ad affrontare e legge i segni dei tempi, definisce l’IA uno strumento affascinante e tremendo, capace di apportare grandi benefici, ma anche di generare pericoli. Il grande entusiasmo per le sue immense potenzialità si accompagna al timore per le conseguenze negative che potrebbero derivare da un suo uso sconsiderato: “Il tema dell’IA è, tuttavia, spesso percepito come ambivalente: da un lato, entusiasma per le possibilità che offre, dall’altra genera timore per le conseguenze che lascia presagire”. Il suo impatto positivo o negativo dipende dall’uso che ne fa l’uomo. Il Papa sottolinea la necessità di un’etica e di una sana politica per guidarne lo sviluppo e l’applicazione e mette in guardia dal rischio di delegare alle macchine decisioni umane, soprattutto quando queste hanno un impatto sulla vita delle persone. Serve “un’algoretica”, per questo ha salutato con grande favore la firma a Roma, nel 2020, della Rome Call for AI Ethics. Concetto di algoretica che viene messo bene in luce da Paolo Benanti nei suoi diversi scritti.
Come aveva fatto notare più Stefano Rodotà, anche il corpo umano è in continua trasformazione. Da tempo ha perduto la sua unità, si è scomposto nelle sue parti, nei suoi prodotti: organi, tessuti, cellule, gameti possono essere separati dal corpo d’origine, fatti circolare ed essere utilizzati in altri corpi. Il corpo fisico ha così conosciuto la crisi della sua materialità quando si è cominciato a contrapporre ad esso il corpo «elettronico».
Nell’Information Age anche il corpo è stato subito considerato un insieme di dati, un sistema informativo, questo aspetto risulta ancora più evidente alla luce degli incessanti progressi compiuti dalle tecnologie ICT, per tutte le varie applicazioni sviluppate nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, che nel medesimo tempo rappresenta il punto di partenza iniziale e l’obiettivo ultimo finale della storia evolutiva dell’informatica. Quando parliamo di Intelligenza Artificiale, dovremmo sempre chiederci, come rileva Kate Crawford, “che cosa viene ottimizzato, per chi e chi è che decide?”.
Uno dei modi di reagire a questa paura è costituito dall’invocare una regolazione e dall’auspicare un intervento del legislatore.
Tornando all’aspetto lessicale, già parlare di intelligenza può essere condizionante. Questa, infatti, si attribuisce agli esseri umani o agli animali, allo stato attuale sarebbe più corretto riferirsi solo al machine learning, ossia a un sistema di apprendimento basato sull’utilizzo dei dati.
Senza voler entrare nell’ampio dibattito scientifico specialistico riguardante l’Intelligenza Artificiale, comprendere il fenomeno è il primo fondamentale passo per valutare le regole applicabili, come applicarle e se sia necessario crearne delle nuove. La qualificazione del fatto alla luce delle norme è un’operazione essenziale del ragionamento giuridico. Si pone, quindi, in primis, un problema metodologico. Spesso trascurato, sul quale rinnovare la consapevolezza, non solo del giurista: è necessario comprendere se e quali interventi normativi siano realmente necessari. È bene subito precisare che le regole sono necessarie, ma occorre non cadere nelle insidie legate alla legislazione dell’emergenza, l’urgenza di placare l’ansia deve cedere il posto alla ponderazione, per concepire norme capaci di regolare il fenomeno nel lungo periodo, neutre da un punto di vista tecnologico.
Il primo obiettivo da perseguire è quello di salvaguardare la persona umana dai rischi e dai pericoli conseguenti alla diffusione di applicazioni basate sull’uso dell’intelligenza artificiale. Un uso distorto dei sistemi di Intelligenza Artificiale può pregiudicare i valori su cui si fonda la stessa Unione europea e causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alle libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale (ove applicabili in determinati settori), la protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale, nonché la tutela dei consumatori. Tali rischi potrebbero derivare da difetti nella progettazione complessiva dei sistemi di Intelligenza Artificiale (anche per quanto riguarda la sorveglianza umana) o dall’uso di dati senza che ne siano state corrette le eventuali distorsioni. Si tratta, quindi, di individuare dei principi cardine da salvaguardare.
L’Europa ha cercato di fornire una risposta a questi rischi con il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale. L’esigenza di optare per un regolamento nasce indubbiamente dalla necessità di avere una normativa applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, un set di regole condivise che facilitino la messa sul mercato europeo di nuovi prodotti e servizi, ma nello stesso tempo aumentino il grado di fiducia degli utenti rispetto all’uso di queste tecnologie, per costruire un sistema di riferimento giuridico uniforme e omogeneo a livello europeo.
Vorrei, però, ricordare, oltre alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il Manifesto di Vienna per l’umanesimo digitale, un vero e proprio appello a riflettere e ad agire sullo sviluppo tecnologico attuale e futuro. Le tecnologie digitali stanno minando la società e mettendo in discussione la nostra comprensione di cosa significhi essere umani. La posta in gioco è alta e l‘obiettivo di costruire una società giusta e democratica in cui le persone siano al centro del progresso tecnologico è una sfida da affrontare con determinazione e inventiva scientifica. L‘innovazione tecnologica richiede innovazione sociale e l‘innovazione sociale richiede un vasto impegno sociale.
Sergio Niger
Niger