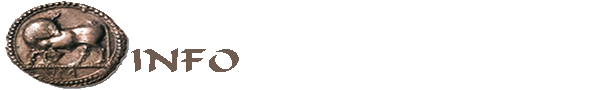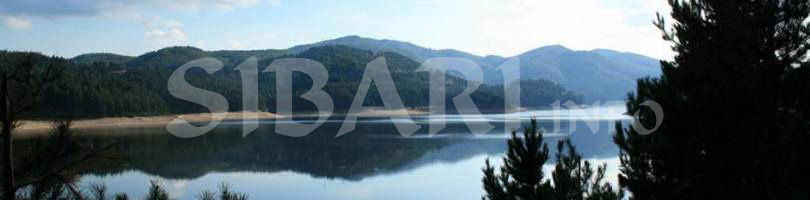Grande assise sabato 29 marzo u. s. nella Basilica di San Giovanni in Laterano, convocata dal Cardinale Vicario di Roma Angelo De Donatis, a discutere i risultati del rapporto del CENSIS su “Gli italiani e la fede”.
Grande assise sabato 29 marzo u. s. nella Basilica di San Giovanni in Laterano, convocata dal Cardinale Vicario di Roma Angelo De Donatis, a discutere i risultati del rapporto del CENSIS su “Gli italiani e la fede”.
Di grande prestigio il panel: oltre al Cardinale Vicario che ha introdotto i lavori, il fondatore del Censis Giuseppe De Rita, il figlio Giulio attuale direttore, Don Fabio Rosini, Massimo Cacciari, Antonio Spadaro, Andrea Riccardi fondatore di Sant’Egidio. Il rapporto ci dice che il 75% del campione intervistato si riconosce nel Cattolicesimo, nella sua base culturale, nell’insegnamento di Gesù, e solo il 5% si dichiara ateo e/o anticattolico, comunque lontano da tutto ciò che il Cattolicesimo rappresenta.
Oggetto di riflessione di tutti gli interventi, quella che è stata definita la zona grigia, ben il 55%. La religiosità di questa zona grigia è emozionale ed individualista, nel senso che non sente di condividerla nelle organizzazioni ecclesiali. Sono credenti ma non presenti. Una buona metà di questa zona grigia è comunque interessata alla trascendenza e chiede una Chiesa che sappia confrontarsi col mondo contemporaneo e perciò disposta a farsi intercettare, ma non a conquistare, evangelizzare, ma come ha ben compreso Spadaro, ad essere abitata. La Chiesa può rispecchiare questa spiritualità diffusa, ma non si tratta di portarla all’ovile. La vita spirituale di questa parte non è morta, ma ha preso parte fuori la Chiesa. Non si tratta di scegliere tra Dio e il mondo, ma Dio nel mondo, per rendere testimonianza della creatività dello spirito.
Papa Francesco ha indicato la strada da seguire quando ha usato un’espressione spagnola mal tradotta, con disinstallarsi, lasciare la situazione di sentirsi sistemati e cominciare ad andare. Seguire il gesuita Ignazio, che nel suo dinamismo abita le stazioni di un cammino, e non la stanzialità del monastero di Benedetto. Farsi popolo pellegrino, proiettare la Chiesa nella zona grigia dove è possibile rinvenire lo spirito. Se è vero che la chiesa ha perso ormai da secoli la regia del film della storia, è comunque fondamentale la sua partecipazione con altri, a questo film.
Il popolo per Riccardi c’è, ma è altrove. E’ fatto di fideles che ha una sua spiritualità, ma non ha il gusto della simultaneità, che non accorre quando suona la campana. Non lo conosciamo e per intercettarlo propone di aggiornare la visione dell’organizzazione ecclesiale più diversificata, in definitiva di andare oltre la cultura del declino. L’attuale individualismo religioso è figlio comunque dell’individualismo culturale della nostra epoca. Bisogna farsi rabdomanti spirituali, per cogliere i segni di speranza che vanno oltre gli io, del resto lo spirito soffia dove vuole.
Al 60% che pensa che la Chiesa sia senza futuro, il cardinale Martini rispondeva tempo fa, che le singole chiese sono legate al loro futuro e ne portano la responsabilità. Giulio De Rita si era chiesto quanto di questo cambiamento dipendesse dal cambio di pelle della Chiesa e quanto da una naturale erosione, inarrestabile in quanto riguarda i giovani.
Don Fabio Rosini ricorda che è nella natura del Vangelo, lo scacco e il rifiuto. Si chiede quanto questo Cattolicesimo senza prassi, sia figlio della cultura moderna e quanto di una Chiesa solo preoccupata della visibilità, che pensa di essere capopopolo senza trascendenza. Invita a mettersi all’opposizione di un potere che non la riconosce, piuttosto che inseguirlo per averne una fetta. I predicatori non si pongano come censori etici, ma riprendano le parole evangeliche di sforzo e impegno; bello e facile non sono compatibili! Che sia la Chiesa, sede del sublime e non del godimento di comodità.
Eccentrico il discorso di Cacciari. Parte dalla teorizzazione di Max Weber del lavoro spirituale e del lavoro politico. Un ossimoro l’associazione di spirituale al lavoro dopo la teoria marxiana e l’esperienza dei tanti lavoratori espropriati del prodotto del loro lavoro, ma per Weber il lavoro spirituale era riferito a quello dello scienziato che vi trova soddisfazione quando la sua ricerca persegue fini universali e non beni individuali, quando è disincarnata dal potere economico. Ma chi può salvaguardare la spiritualità del lavoro dello scienziato se non l’homo politicus che persegue fini universali propri della politica? Il politico deve salvaguardare la forza produttiva dell’intelletto e sottrarre lo scienziato al potere economico finanziario. Ma i giochi ormai sono fatti: l’uomo tecnico ha soppiantato lo scienziato e l’uomo politico è morto, e con lui la trascendenza. La fine della vocazione politica coincide con la fine della vocazione religiosa. Da qui l’esigenza di una elite politica in grado di interpretare l’interesse generale, e di un’alleanza dello spirito che assuma le contraddizioni della modernità. La vera politica indica i fini che, come si è detto, non sono individuali, ma hanno a che fare con la trascendenza.
Giuseppe De Rita riprende la definizione di Cacciari di spirito come energia che mette in relazione, necessario a superare il soggettivismo etico imperante in nome della libertà. Nella zona grigia anche per De Rita c’è tanta spiritualità, poco importa che non sia ecclesiale.
Chi ha avuto la pazienza di leggere fin qua avrà notato che assente da questo dibattito è la riflessione sulla fede dei praticanti che andrebbe compresa e rafforzata se si vogliono evitare altre erosioni e smottamenti.
Giuseppe COSTANTINO