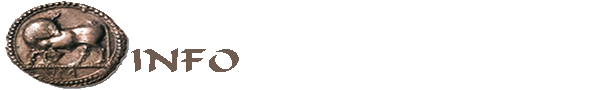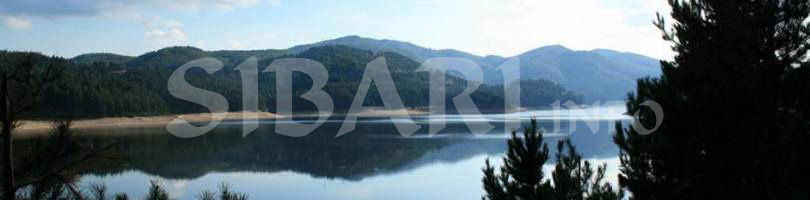Il recente articolo/intervista al prof. Mario Sirimarco, pubblicato sul nostro sito, si concludeva con la frase: "Il vero rischio è proprio la fine dell’individuo, la disponibilità su di esso esercitata dai detentori del potere; il vero pericolo è che l’uomo diventi “superfluo”. Ed è un pericolo ancora molto attuale", che mi ha indotto a stimolare alcuni amici esperti in materia giuridica, proponendo la seguente domanda: “Si può scongiurare questo pericolo e in che modo? La forma di democrazia occidentale è in grado di farlo?”
Il recente articolo/intervista al prof. Mario Sirimarco, pubblicato sul nostro sito, si concludeva con la frase: "Il vero rischio è proprio la fine dell’individuo, la disponibilità su di esso esercitata dai detentori del potere; il vero pericolo è che l’uomo diventi “superfluo”. Ed è un pericolo ancora molto attuale", che mi ha indotto a stimolare alcuni amici esperti in materia giuridica, proponendo la seguente domanda: “Si può scongiurare questo pericolo e in che modo? La forma di democrazia occidentale è in grado di farlo?”
Mi sono giunte diverse risposte, molte in modalità telegrafica, ma quella che vi propongo è abbastanza circostanziata e credo che possa suscitare anche l’interesse di voi amici/lettori del sito. Buona Lettura. (Antonio M. Cavallaro)
Ho letto con attenzione l’intervista al prof. Sirimarco su Giuseppe Capograssi, filosofo e giurista, pubblicata sul sito infosibari.it e condivido l’allarme del gestore, Antonio Michele Cavallaro, sulla constatazione rinvenibile nella frase del Capograssi che <<Il vero rischio è proprio la fine dell’individuo, la disponibilità su di esso esercitata dai detentori del potere; il vero pericolo è che l’uomo diventi “superfluo”>>.
Ma il Capograssi, uno dei primi componenti della Consulta, non fece in tempo a vedere quell’organo vitalizzare e dare sostanza ai primi tre articoli della costituzione che esaltano la persona umana come centro motore di tutto il sistema e come fine da perseguire da parte di tutte le istituzioni, fino all’avvento della mercificazione col dio denaro e la persona umana al servizio del denaro e non più il contrario.
Evitando localismi, in generale direi che per qualcuno il potere consiste nel fatto di essere in grado di abusarne.
Già nel 2018 il grande magistrato e giusfilosofo Otello Lupacchini ha pubblicato un saggio molto interessante “Paura e Potere” indicando un rapporto tra la violenza, ossia un comportamento al di fuori delle regole, ed il potere come controllo della forza. La paura funzionale per l’acquisizione e la conservazione del potere, ossia uno dei mezzi attraverso i quali garantirsi il potere e l’obbedienza duratura.
Senza andare troppo lontano allo “iustitium” romano con la sospensione del diritto a favore dei consoli che avevano un potere assoluto per sei mesi con la giustificazione del “tumultum” interno e/o di pericolo esterno; più vicino a noi, nella Germania anteguerra, con i decreti del capo di quel governo e, recentissimamente (forse lo abbiamo dimenticato) con i famigerati dpcm e la conseguente sospensione della costituzione, addirittura con la proclamazione dello stato d’emergenza, istituto non previsto dalla costituzione.
Ecco perchè i detentori del potere, ossia i politici e tutti coloro che sono chiamati ad esercitare cariche pubbliche, sono vincolati dall’art. 54 della costituzione che parla appunto di esercizio di quelle funzioni con disciplina e onore, Concetti che il prof. Gustavo Zagrebelsky ha così sintetizzato.
“L’onore consiste nella fedeltà al principio dell’interesse pubblico. Coloro che sono investiti di una funzione pubblica devono comportarsi con onore, ossia per l’interesse generale della comunità.”
Dunque, bisogna avere un forte senso dell’interesse pubblico a cui essere fedele. Se non si é fedeli all’interesse pubblico ci si comporta in maniera contraria alla costituzione.
La disciplina è un’altra cosa. Vuole escludere dalla vita pubblica gli sbruffoni, coloro che parlano a vanvera, coloro che insultano, coloro che non si comportano con un minimo di decoro civile…
In questo contesto, l’evolversi dell'opera di Leonardo Sciascia (da Il giorno della civetta fino a Todo Modo, che addirittura anticipa una pandemia e che indica come la verità sia sotto gli occhi di tutti ma per questo nessuno la vede) che sviluppa la ricerca della verità ed anche sacrificio per la ricerca della verità che oramai però non vanno più di moda.
Nel film tratto dall’opera di Sciascia, “A ciascuno il suo” diretto dal premio oscar Elio Petri nel 1967: ad un certo punto il grandissimo GianMaria Volontè (che interpreta l’ingenuo prof. Laurana alla ricerca della verità e che per ciò sacrificherà la propria vita) va a trovare il furbo parroco del paese (interpretato da Mario Scaccia) e gli chiede: “un notabile, un notabile che ruba, intrallazza, che fa il bello e cattivo tempo, lei a chi penserebbe?…”
Ed il parroco risponde: “Rosello, l’avvocato Rosello … un cretino non privo di astuzia…che per raggiungere una carica passerebbe sul cadavere di chiunque…”.
Ebbene, i comportamenti di queste persone - cretini ma astuti (e per niente avvezzi al bene comune) - venivano stigmatizzati da Leonardo Sciascia e da Elio Petri già nel secolo scorso e sarebbe il caso di ribadire sempre tale connotazione negativa.
Avv. Bernardo Bordino,
consigliere distrettuale
di disciplina degli avvocati