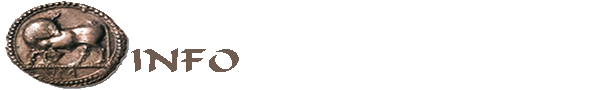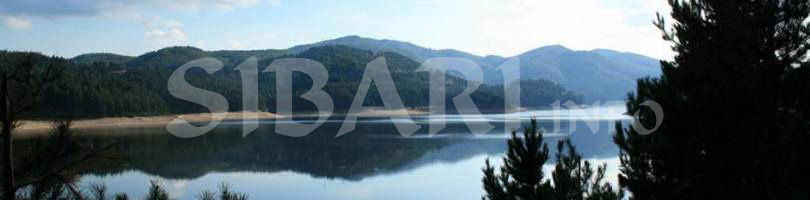Il 31 Marzo scorso si é tenuta a Roma un'interessante conferenza su argomenti più che mai attuali: intelligenza artificiale e conformazione delle città in funzione delle nuove tecnologie e delle nuove socialità. A dialogare sulle tematiche due personaggi di notevole caratura: Massimo CACCIARI e Alessandro BIANCHI.
Il 31 Marzo scorso si é tenuta a Roma un'interessante conferenza su argomenti più che mai attuali: intelligenza artificiale e conformazione delle città in funzione delle nuove tecnologie e delle nuove socialità. A dialogare sulle tematiche due personaggi di notevole caratura: Massimo CACCIARI e Alessandro BIANCHI.
Di seguito pubblichiamo le impressioni del prof. Giuseppe Costantino presente a quell'importante evento culturale.
Alessandro Bianchi inizia il suo intervento facendo riferimento alle problematiche suscitate dalla crisi climatica, dalla demografia, e dalla crescita esponenziale della popolazione mondiale, con un’Europa che ha la stessa popolazione da cinquant’anni, mentre l’Africa in questi anni è arrivata ad un miliardo e mezzo e continuerà a crescere. L’altro problema le disuguaglianze crescenti. Insieme a queste tre crisi l’intelligenza artificiale si sta imponendo come soluzione, ma suscita dubbi e perplessità di natura etica.
Cacciari considera il tema di frontiera, e ritiene per questo impossibile poterlo trattare in modo sistematico. Le trasformazioni più significative cui abbiamo assistito negli ultimi cinquant’anni sono il superamento della forma città, per diventare città infinita o città territorio. Per il cambiamento demografico, la maggioranza della popolazione mondiale vive nelle città, molte delle quali superano i venti milioni di abitanti. Ma queste possono continuare ad essere chiamate città? Ma anche città come Milano Roma, Napoli sono sempre più degli insiemi cresciuti, all’apparenza, in modo spontaneo senza una reale programmazione. Le città come le abbiamo conosciute noi si possono identificare solo nei centri storici ormai museizzati.
A tutte le diverse e confuse presenze che costituiscono il territorio, come fai a garantire le relazioni? Si chiede Cacciari. La Metropoli di inizio novecento, oggetto di studio di sociologi, urbanisti e architetti era comunque facilmente organizzabile. C’era una razionalità nel distribuire le diverse funzioni: la residenza, la produzione, il consumo e ognuna di queste funzioni aveva la sua forma, la sua architettura.
Fino a cinquant’ anni fa si poteva parlare di Piano regolatore che sottintendeva l’idea di un governo politico del territorio. Adesso è una prospettiva irrealistica. La buona utopia sarebbe quella che l’urbanistica e l’architettura inseguissero questa nuova complessità progettando centri polivalenti ibridando le diverse funzioni, ma gli interventi attuali sono del tutto inadeguati alla straordinaria complessità. Sembra sia sparita nella grande architettura l’idea di elaborare una forma urbis specifica. Ormai gli architetti fanno le stesse cose nelle diverse parti del mondo. Non rimane ai nostri amministratori che raccordare l’esistente.
La crisi climatica sta accentuando l’urbanizzazione. Masse di disperati creano bidonvilles di milioni di abitanti non governate, dove è impossibile inserire una metrica, cosa che invece è stato possibile nelle metropoli che si sono sviluppate tra otto e novecento, mentre una parte minima della città territorio è abitata dalla minoranza burocratizzata, addirittura superiore al periodo coloniale e che è la sola a poter essere governata.
Quando parliamo di città continuiamo a parlare delle città dell’uomo bianco che fino ad un secolo e mezzo fa era maggioranza della popolazione mondiale.
L’intelligenza artificiale in questo contesto diventa indispensabile per inventare una metrica che ci permetta di governare la città territorio, dove a farla da padrone sono le disuguaglianze economiche, sociali e culturali in un tutto indistinto, al contrario della metropoli dove le classi sociali erano motore e strumento in grado di formare la volontà politica. Ma anche qui, da cinquant’anni a questa parte l’homo politicus sembra sia scomparso, soppiantato dall’homo technicus. Nelle metropoli si poteva pensare ad un governo politico e ad un’architettura politica. Nelle vecchie città l’uomo metteva radici attraverso una casa, un lavoro, una propria funzione e chi amministrava la città organizzava urbanisticamente gli spazi con luoghi pubblici come viali e piazze. Ma oggi che senso ha costruire piazze dove nessuno vi si fermerà, piste ciclabili che nessuno percorrerà o anfiteatri che nessuno frequenterà?
Se la volontà politica è in distonia totale con la realtà, affidiamoci all’intelligenza artificiale che diventa uno strumento formidabile per razionalizzare questi spazi. Se gli si danno le informazioni adeguate sarà capace di suggerire ad esempio agli amministratori delle grandi città come regolare il traffico. Vero che siamo lontani dall’idea di progetto, di dover essere dell’uomo, ma fin quando il politico è in ritardo o non è in sintonia con i bisogni degli amministrati l’AI può sempre dare dei buoni consigli. Si può ripensare l’assetto amministrativo, dalle Regioni alle Province, ai piccoli e grandi comuni per efficientare i servizi, ma i politici sono ontologicamente in ritardo rispetto al potere economico, finanziario e scientifico, alla sua accelerazione, alla sua velocità. Da qui l’intelligenza artificiale, che con la sua potenza di calcolo, la capacità di connettere le diverse dimensioni dei problemi ci può suggerire delle buone soluzioni e poi, ovviamente, starà a noi utilizzarli.
Questa la prospettiva buona, eutopica ma poi c’è anche quella distopica perché questi mezzi non sono solo mezzi a nostra disposizione, ma hanno una loro interna logica che è quella di sistemi economico finanziari e non tanto dello scienziato che non è più libero, e il prodotto del suo lavoro è controllato dal sistema economico finanziario, che è poi quello che aveva teorizzato Karl Marx a proposito del lavoro in generale, il cui prodotto veniva espropriato dal padrone.
La distopia quale può essere? Se noi ci affidiamo alla potenza dell’intelligenza artificiale, la cui logica è riduttivistica, omologante che fa funzionare le cose perfettamente, come funziona perfettamente un formicaio, un alveare dove scompare il lavoro dell’individuo a favore del lavoro dell’organismo. Un sistema che si autoregola dove la volontà dell’individuo non conta nulla. Un intelletto generale che governa le comunità, questa la distopia della fantascienza che è passata dall’ideologia progressista al servizio del nostro benessere, a quella distopica che fa tutto, che regola tutto compresa la vita della gente. Ma la fantascienza, dice Cacciari, non va sottovalutata perché quello che aveva immaginato poi si è realizzato. Pertanto l’AI va affrontata nella sua inevitabilità, nella sua efficacia nella misura che sia politicamente governata, ma anche nella sua carica distopica.
L’altra frontiera da affrontare è quella scientifica, medica e politica, perché influenzerà la rete neuronale. L’AI avrà un suo cervello.
Ma quale cervello? Si chiede Cacciari. Un cervello universale compreso anche delle qualità affettive in grado com’è di interagire, in grado di apprendere anche i sentimenti. E’ un problema se diventa un modello universale cui adeguarsi, utile se rimane uno strumento che corrisponde alle nostre domande. Difficile prevedere quale avrà la meglio, se la buona utopia o la distopia. In ogni caso può tornare utile all’organizzazione della città in mancanza e, nell’impossibilità di una politica espressa da una città che un tempo aveva un’organizzazione razionale.
Cacciari ha reagito in modo appassionato, quando gli é stato ricordato come fosse liquidatorio da parte sua definire ontologico il ritardo dell’homo politicus, con queste parole: "La vera utopia sarebbe quella di un’alleanza tra politica e scienza. L’uomo politico potrà trarre vantaggio da una scienza libera svincolata dai potentati economici che ne orientano l’attività, a patto che sia in grado di garantirne la libertà".
Alessandro Bianchi dopo aver ringraziato il Prof. Cacciari per l’interveto, ha dichiarato l’ambizione di voler fondare una Scienza della città per ridefinirne i fondamenti, con i contributi di filosofi, storici, sociologi, architetti e urbanisti.
 Giuseppe Costantino
Giuseppe Costantino